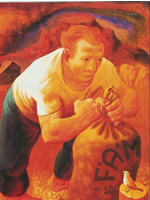|


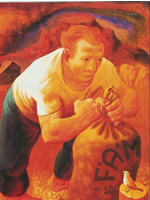
|
CARLO
SARTORI PITTORE DI GODENZO - di Maria Marsilli
L'amore
per la natura e per la propria terra, è particolarmente
radicato nell'animo dei poeti e degli artisti.
Anche Carlo Sartori, in un incontro che ho avuto recentemente
con lui, a Godenzo, prima ancora di mostrarmi i suoi quadri, motivo
della mia visita, mi offerse, con occhi scintillanti e con ampio
gesto della mano, la visione della Valle, in un atto di fede e
di compiacimento.
A Godenzo, che sempre lo affascina, Carlo Sartori vive da quarant'anni.
Si chiama Godenzo un paesetto del Comune di Lomaso, situato al
limite Est della Val Giudicarie, in una dolce piana di ampio respiro
di campi e prati, in una cerchia di montagne che aprono uno spiraglio
all'affacciarsi di alcune cime del Brenta e dell'Adamello, pregne
di soavità. Conta 400 abitanti che fino a qualche anno
fa vivevano miseramente del ricavato dei loro piccoli campi. Con
il sorgere di alcune fabbriche nei Comuni vicini, i giovani di
Godenzo sono andati là, in cerca di un guadagno che desse
loro la possibilità di una vita meno dura. Senza rinunciare
tuttavia alla coltivazione della terra, alla quale dedicano le
ore libere dal lavoro di fabbrica, coadiuvati dalle persone anziane
rimaste al paese, e dalle macchine agricole. Ma le piccole stalle
del paese,ovviamente, sono state vuotate dei loro animali.Perché
non vale certo il diuturno sacrificio di un uomo per curare una
o due sole bovine. A colmare questo vuoto, sono però sorte
a Godenzo quattro imprese zootecniche d'una certa consistenza,
una delle quali raggiunge i seicento capi di bestiame. Sono stalle
razionali,dotate di servizi automatici,che riducono notevolmente
la mano d'opera e le relative spese.
Carlo Sartori giunse a Godenzo, proveniente da Ranzo, all'età
di dieci anni,insieme con la famiglia paterna: una famiglia patriarcale.
A Ranzo, il padre di Carlo, Paride Sartori, uno dei pochi valligiani
che non si dedicasse alla terra, faceva il calzolaio. E la sera,
per divertire i suoi undici figlioli, costruiva giocattoli con
mano agile e sapiente. La produzione di scarpe, di lui che era
considerato in tutta la Valle l'artigiano-artista del settore,
era ricercatissima. Le confezionava a mano, con somma cura, senza
l'ausilio di macchine, e le garantiva per una durata di tre anni.
Ma il guadagno che ne ricavava, non aveva durata alcuna. Con tutte
quelle bocche da sfamare, spariva come neve al sole!
Fu così che i figli man mano che crescevano, dovettero
assoggettarsi troppo presto a qualche attività, per sollevare
in certo qual modo il padre dal grave carico di famiglia.
Carlo, sesto dei figli, insieme con il fratello maggiore, iniziò
a nove anni la dura esperienza dell'alpeggio. Dai contadini della
Valle veniva affidato alla loro custodia un branco di quaranta
manze, verso un compenso di dieci lire al giorno; multe a loro
carico (qualora le bestie fossero entrate sui terreni altrui o
avessero danneggiato piante o cose).
Lassù, nella malga Naone (ora abbandonata), i pasti giornalieri
dei ragazzi si riducevano a polenta e formaggio. Mai niente di
più o di diverso. Dormivano nel sottotetto d'un vecchio
baraccone adibito al ricovero notturno del bestiame, in un piano
tirato su con quattro assi traballanti, disposte sopra la stalla.
Nelle notti che seguivano le giornate di pioggia, i due fratelli
si coricavano nel loro giaciglio, inzuppati d'acqua, e ne uscivano,
la mattina seguente, ancora bagnati. Perché un ricambio
di indumenti, non si poteva neanche sognarlo. E l'aria della baracca,
pregna del respiro degli animali, era pesante.
La stagione dell'alpeggio era lunga: si protraeva fino a novembre.
Carlo, quando ritornava al paese, lo sentiva estraneo, anche se
più ricco colore e di vita umana.
Tutto ciò che accadeva nel mondo degli uomini, impressionava
tristemente il ragazzo che ormai si sentiva più vicino
al monte e agli animali, che per lui erano pieni di richiamo e
di significato.
Tutto ciò che accadeva nel mondo degli uomini, impressionava
tristemente il ragazzo che ormai si sentiva più vicino
al monte e agli animali, che per lui erano pieni di richiamo e
di significato.
Era attratto però dalle funzioni religiose, in cui vedeva
il folclore, le scene di vita più movimentate. Rifaceva,
in casa e sulle strade, le prediche del parroco, le processioni
e i funerali, travestendo se stesso e i suoi compagni da preti,
e seminando lo scandalo fra i paesani.
Poi seguiva l'opera dell'imbianchino, senza tuttavia presagire
che un giorno quel lavoro sarebbe toccato anche a lui."Che
ghe metet giò-gli chiedeva-per far quel color? E per far
quel altro?" Indi provava e riprovava a spennellare qualche
pezzo di muro della sua casa,usando estratti di bacche e di erbe,
o terrette. Finché la coprì tutta, trasformandola
in una ridente tavolozza.
Disegnava tutto ciò che accadeva in paese, a tergo di immaginette
che gli donava il parroco, dato che altra carta in casa non c'era.
Da quanto egli racconta,si ha però l'impressione che gli
desse più gioia l'incidere, con l'uso d'un temperino, sulla
corteccia degli alberi,figure di animali della montagna. È
ritrovabile ancora oggi a Malga Naone, sul tronco d'un faggio,
un suo disegno di un capriolo, che s'è allargato smisuratamente
con il crescere della pianta.
Degli anni giovanili di Carlo, c'è infine il capitolo della
scuola,che pesa nei suoi ricordi. Frequentò solamente le
"elementari"del paese, che avevano cinque classi. Nei
primi due anni, fu il primo della classe. Ma in terza, forse per
l'incomprensione di una nuova insegnante, tornò a zero.
Poi vennero la quarta e la quinta classe, fastidiose, perché
ripetute più volte, in attesa del raggiungimento dei quattordici
anni, che segnavano anche allora il limite di età dell'esenzione
dall'obbligo scolastico.Unica sua soddisfazione:il privilegio
d'esser stato sempre prescelto ad illustrare sulla lavagna i fatti
salienti della Storia d'Italia, e qualche schizzo topografico.
Ma ecco che finite le elementari, lo prende una tale sete di sapere,
che lo avrebbe sottoposto a qualsiasi sacrificio, pur di continuare
gli studi. Ma le "Medie"erano lontane. Richiedevano
spese. E denaro non ce n'era.
Fu allora che Carlo Sartori si accinse a fare l'imbianchino e,
nelle ore libere dal lavoro, si mise a studiare da solo, sui pochi
libri che poteva acquistare o avere a prestito, nonché
a disegnare e a dipingere sullo sfondo ideale del suo paesaggio
e della sua passione.
Finché venne la guerra (la seconda guerra mondiale),che
lo portò via, in un campo di concentramento tedesco, ove
anche lui soffrì i patimenti fisici e morali che molti
di noi conosciamo.
Carlo Sartori ha ora i capelli bianchi, ma ancora folti, con la
spaccata. Occhi scuri, spalancati, estasiati. Corporatura tarchiata
e passo cadenzato, da montanaro; e montanaro è rimasto
dentro.
Racconta la triste storia della sua infanzia e della sua giovinezza,
senza risentimenti; anzi,con voce carica di vivacità e
illuminata da ottimismo. Il suo cuore caldo, anche ora che la
sua esistenza è migliorata è rimasto aperto all'uomo
che vive duramente, e agli animali. Li conosce, li comprende,
li ama. Perciò, nel suo istinto artistico, nella sua arte
figurativa che è nata in lui con una forza impellente,
sono sempre loro i suoi soggetti preferiti.
Dalle sue figure emana un respiro che non può essere interpretato
che come un messaggio d'amore.
A prima vista, le dimensioni delle sue immagini appaiono pesanti
e rigonfiate. Ma poi piacciono molto, perché sono personalissime
e coerenti.
Alcuni critici lo avvicinano, per concezione, all'artista Gino
Pancheri di Trento; altri affermano che si sia ispirato a Vincent
van Gogh. Ma il Sartori ribatte di non esser mai stato influenzato
da alcuno. Autodidatta, approdò a se stesso con il suo
sentire e con l'apprendere dalla natura e dalla vita.
Nella pittura gli piacciono e usa solitamente, con impeto selvaggio,
colori squillanti e puri, come l'arancio, il rosso e l'ocra.
Oltre ad altri validi riconoscimenti, Carlo Sartori, con la sua
opera intitolata"Scampagnata", vinse, nel 1971, il "Primo
premio ex aequo" a Luzzara di Reggio Emilia, in una importante
Mostra (trasferita successivamente a Bologna e a Milano), riservata
ai "Naifs" di tutta Italia.
L'opera sua prescelta viene conservata nel Museo Nazionale dei
Naifs, che ha sede a Luzzara, unico del genere in Italia.
Da allora, la pittura di Carlo Sartori va sempre più accrescendo
il suo apprezzamento ed è ricercata sia dalle Gallerie
d'arte che dai collezionisti.
Si direbbe che a concepire il suo felice impasto di colore e di
calore umano, il suo orizzonte di sensibilità, sia sta
appunto la sua sofferenza, quella che nasce dal connubio della
povertà con l'ingegno e che perciò, essendo più
spesso genuina ed autentica, ha costituito nel Sartori il ruolo
determinante della sua formazione artistica, che perdura, per
elevarsi in una sempre più completa presa di possesso dei
motivi intorno ai quali il suo cuore e il suo estro si sono cementati:
la vita contadina, fine a se stessa.
Più che le parole, lo testimoniano i vari quadri qui riprodotti,
dove l'uomo e l'animale s'inseriscono felicemente nella scena
e divengono il soggetto idillico che acquista un singolare vigore,
e un discorso senza fine.
Da:
Il seme. Rivista di agricoltura, n.2, marzo-aprile 1974.
|